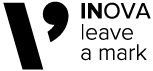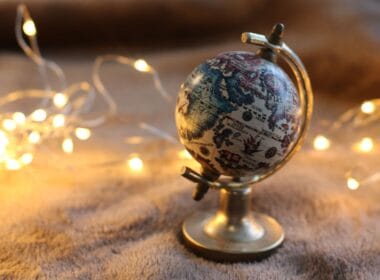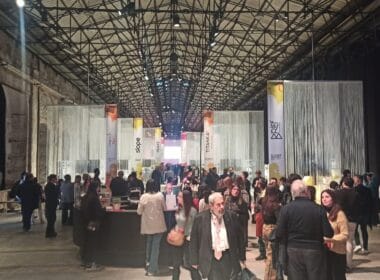Prima di partire per un viaggio, c’è sempre una fase di immaginazione e di sogno. E spesso sono quelle che potremmo definire le narrazioni artistiche – un dipinto, un romanzo, un film, perfino una canzone – a instillare quella scintilla di desiderio iniziale.
Con il ciclo di articoli Turismo d’autore, vogliamo provare a esplorare, senza pretesa di esaustività, come l’arte in tutte le sue forme abbia contribuito a costruire il nostro immaginario turistico, dapprima in modo inconsapevole e spontaneo, poi sempre più strutturato, diventando, talvolta, vero e proprio strumento di promozione territoriale. Un percorso in quattro tappe, tra arti figurative, cinema, letteratura e musica, per capire come le opere di ogni tempo, in ogni tempo, abbiano reso luoghi e città non semplici scenari ma “destinazioni”.
Indice dei contenuti:
- Dal Rinascimento al mito del Grand Tour
- Quando l’arte diventa destinazione
- La città-tela contemporanea: street art e rigenerazione urbana
Dal Rinascimento al mito del Grand Tour
Ben prima che nascesse l’industria del turismo, la pittura, la scultura e, naturalmente, l’architettura hanno contribuito a trasformare luoghi e città in mete di viaggio. Niente più dell’arte aveva – e ha tuttora – il potere di costruire l’immagine che abbiamo di un luogo, prima ancora di farne esperienza diretta.
Pensiamo al Rinascimento fiorentino o al Barocco romano. Intere generazioni di viaggiatori, nei secoli, hanno imparato a riconoscere Firenze attraverso le forme eleganti e armoniche dei suoi edifici storici, le pale d’altare, le statue che arricchiscono le piazze oppure hanno immaginato Roma grazie alla visione delle sue cupole imponenti, delle grandiose fontane o degli affreschi che ne celebravano il fasto.

Nel Settecento il desiderio di conoscere l’arte e i suoi luoghi si trasformò in un vero e proprio rito di formazione: il Grand Tour. Giovani aristocratici e intellettuali intraprendevano lunghi viaggi verso l’Italia per completare la propria educazione. Non si trattava solo di visitare musei e rovine, ma di entrare in contatto diretto con ciò che avevano visto fino ad allora solo nei libri o nei dipinti. Firenze, Roma, Venezia, Napoli: ogni tappa era una lezione viva di storia, arte e bellezza. L’arte, in questo senso, ha rappresentato davvero la prima forma di promozione turistica.
Quando l’arte diventa destinazione
Un fenomeno che attraversa i secoli, perché legato al potere immaginifico intrinseco all’opera d’arte.
Basti pensare agli impressionisti francesi, che con le loro tele en plein air hanno reso immortali e universalmente riconosciuti paesaggi naturali e rurali, città e monumenti della Francia, da Parigi alla Normandia: la cattedrale di Rouen, le bianche scogliere di Etretat, i boulevard parigini, la campagna lungo la Senna… Lo stesso accadde, ad esempio, con Vincent van Gogh, che trasformò Arles e la Provenza in scenari mitici, tra campi di grano, cieli stellati e girasoli, che ancora oggi attraggono sulle sue tracce viaggiatori di tutto il mondo.

È tra fine Ottocento e Novecento che si entra in una nuova fase, più strutturata: l’immaginario turistico non è più affidato solo alla potenza evocativa di un’opera, ma diventa strumento sempre più consapevole di attrazione. I musei diventano poli turistici, gli itinerari culturali si consolidano, nascono le città d’arte così come le intendiamo oggi. Visitare gli Uffizi a Firenze, il Louvre a Parigi o il Prado a Madrid non è più un privilegio per pochi, ma diventa progressivamente una tappa imprescindibile per milioni di viaggiatori.
È in questo periodo che si sviluppa una pratica ancora più esplicita di “arte al servizio del turismo”: pittori e illustratori vengono ingaggiati per realizzare manifesti pubblicitari che promuovano città e località di villeggiatura balneari e montane, traducendo l’arte in quelli che oggi definiremmo a tutti gli effetti come strumenti di marketing. Opere di artisti come Marcello Dudovich o Leonetto Cappiello diventano veri e propri veicoli per costruire l’immaginario turistico del nostro Paese.

La città-tela contemporanea: street art e rigenerazione urbana
Anche oggi il rapporto tra arte e turismo continua a far parte della nostra contemporaneità, in una continua oscillazione tra attrattività inconsapevole e funzione strumentale. Oggi l’arte non resta più confinata nei musei: invade le strade, ridisegna quartieri, trasforma borghi e città, appunto, in musei a cielo aperto. La street art non è più solo un linguaggio artistico originale e trasgressivo, ma può diventare leva di rigenerazione e, perché no, di attrazione turistica.
In Italia, il quartiere della Darsena a Ravenna è un esempio emblematico: un’area portuale in trasformazione che negli ultimi anni ha visto l’intervento di artisti nazionali e internazionali e che oggi rappresenta una tappa irrinunciabile per chi cerca l’anima più contemporanea della città. Sempre in Emilia-Romagna, diverso, ma altrettanto significativo, è il caso di Dozza, piccolo borgo medievale famoso per i muri dipinti delle case del centro storico, che ne fanno una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto.

All’estero, il nome che forse più di tutti rappresenta la street art come fenomeno globale è quello di Banksy. Tra Bristol e Londra, turisti e appassionati percorrono i quartieri per cercare le sue opere, icone pop conosciute in tutto il mondo. Un curioso paradosso, se si pensa che lo stesso artista ha spesso denunciato le contraddizioni del turismo di massa e la mercificazione dell’arte. Nonostante il suo messaggio critico, i suoi lavori sono oggi mete di pellegrinaggio turistico e involontari strumenti di marketing urbano.
Il legame tra arte e viaggio, dunque, non appartiene solo al passato ma continua a rinnovarsi, trasformando continuamente i nostri modi di immaginare, guardare e vivere i luoghi. Che si tratti di un affresco rinascimentale, di un manifesto d’inizio Novecento o di un murale contemporaneo, l’arte non smette mai di suggerire ‘destinazioni’, di alimentare desideri e di dare forma ai nostri itinerari, reali e immaginari…