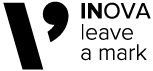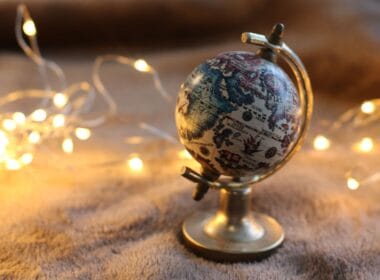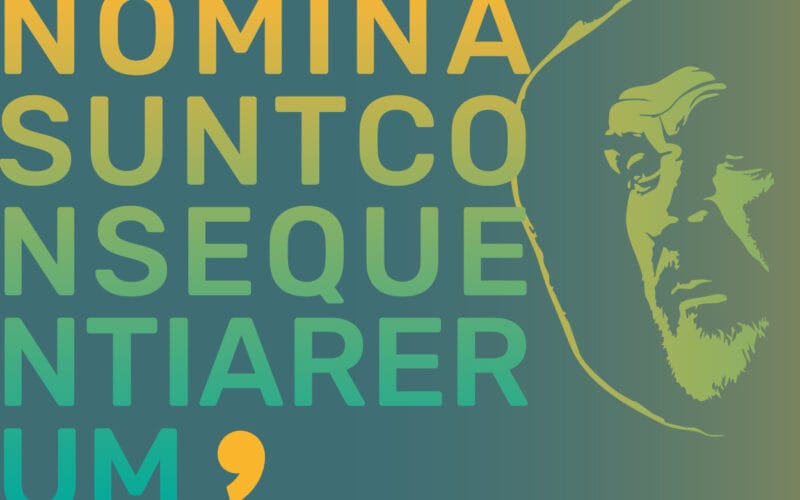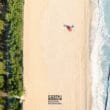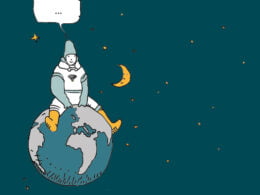Il viaggio di INova nell’estate italiana, accompagnato come sempre dalle illustrazioni di Valeria Morando, incomincia dalle parole. Come si racconta l’identità di un territorio attraverso un brand di destinazione?
Abbiamo provato a rispondere a partire da una mappatura dell’esistente, cercando i luoghi dai nomi più evocativi e riconoscibili per capire se e come siano stati declinati nella comunicazione turistica. O, al contrario, come la comunicazione abbia contribuito attivamente a definire un territorio nell’immaginario collettivo.
Indice dei contenuti:
- Botanica sempreverde
- Tra storia, letteratura e mito
- I fortunati equivoci
- Brand e prodotto
- Tracce umane dal passato
- Conclusioni
Botanica sempreverde
Nel senso più letterale possibile, un territorio si esprime attraverso quello che ci cresce sopra: in giro per l’Italia troviamo moltissimi luoghi che evocano specificità botaniche, antiche o d’importazione.
C’è la Costa Giardino, in Abruzzo: sette località balneari (le sette perle della costa teramana) tra cui Roseto, Pineto, Silvi. È ricca di riferimenti botanici anche la Calabria, ma le piante che hanno attecchito tra le definizioni dei suoi luoghi non sono solo belle e profumate: sono quelle che, storicamente, hanno portato ricchezza al territorio. In provincia di Catanzaro c’è la Costa degli Aranci, in onore dei preziosi agrumeti introdotti forse dai saraceni. C’è poi la Riviera dei Cedri, in alto Tirreno cosentino, habitat naturale del Cedro di Calabria DOP. E in provincia di Reggio troviamo la Riviera dei Gelsomini, fiori importanti per l’economia locale: venivano venduti a peso ed esportati in Francia per creare profumi.
In Liguria incontriamo una storia analoga con la Riviera dei Fiori, estesa dalla Città dei Fiori: un’etichetta che Sanremo porta con orgoglio all’occhiello da più di un secolo. Già a partire dall’Ottocento le profumerie producevano essenze con i fiori locali, mentre il primo grande mercato dei fiori risale ai primi del Novecento. Più tortuosa la storia della Riviera delle Palme: quella parte di Ponente Ligure che ha preso in prestito il toponimo dalle palme piantate a partire dall’Ottocento, oggi nella comunicazione turistica regionale viene definita Ligurian Riviera. La “palma” di Riviera delle Palme è passata invece a un tratto della costa marchigiana, che ha registrato il brand. Curiosità: la stessa parola Riviera in origine definiva solo la Liguria. Oggi è diffusa e amata in altre parti d’Italia, come alternativa di Costa o Costiera.

Tra storia, letteratura e mito
Nel Sud Italia il racconto del territorio passa attraverso un intreccio di storia, leggende e mitologia ellenica: dell’antica colonia di Sibari, in Calabria, rimane traccia nel nome Costa degli Achei. Mentre sul litorale tirrenico meridionale troviamo la Costa degli Dei – scelta come meta addirittura dagli Olimpici, secondo la leggenda, per la sua bellezza.
Le divinità greche passarono però anche dalla Campania: gli otto chilometri da Agerola a Nocelle sono chiamati “Sentiero degli Dei” e vennero percorsi, si narra, per salvare Ulisse dalle sirene che si trovavano nell’arcipelago de Li Galli.
Ma in giro per l’Italia si trovano anche tracce decisamente più moderne, della contaminazione tra letteratura e territorio: la definizione Golfo dei Poeti, ispirata all’amore per il Levante Ligure di artisti come Byron e Shelley, è stata coniata nel 1910 dallo scrittore Sam Benelli nella triste occasione di un’elegia funebre, ed è entrata con successo nell’immaginario collettivo. A Sestri Levante, poi, l’incantevole “Baia delle Favole” è un’invenzione ancora più recente, di Enzo Tortora, rafforzata dal Festival e dal premio letterario dedicato ad Hans Christian Andersen che si svolge ogni anno proprio nel borgo.
I fortunati equivoci
L’incontro tra la lingua italiana e i dialetti locali ha dato origine a equivoci felici: il Massiccio del Gran Paradiso evoca altezze celesti, ma il suo nome, ufficializzato nella prima metà dell’Ottocento, sembra derivare da Grande Paroi o Granta Parei (Grande Parete).

La trentina Val di Sole solletica la fantasia, facendo pensare a una vallata aperta e luminosa, ma il toponimo sol, da cui prende il nome, risalirebbe alla divinità celtica delle acque Sulis. La vicina Val di Non stuzzica il bastian contrario in ognuno di noi, ma potrebbe essere una storpiatura di Valle Anaune, dai Monti Anauni.
Il caso più curioso è però quello di Golfo Aranci, in Sardegna: il toponimo potrebbe infatti derivare da un’interpretazione errata dei cartografi di Gulfu di li Ranci, “golfo dei granchi”. I crostacei si sono adattati con grazia alla metamorfosi in agrumeti e il nome è rimasto inalterato dalla metà dell’Ottocento.
Brand e prodotto
Che si tratti di prodotto tipico locale o di prodotto turistico, in alcuni casi è proprio la comunicazione del prodotto a lasciare il segno nel nome di un luogo. Langhe, Monferrato e Roero si raccontano attraverso un unico marchio (LMR) in virtù dell’eccellenza vinicola condivisa del territorio. Le Colline del Prosecco in Veneto hanno visto il brand nascere e rafforzarsi in seguito al riconoscimento della DOCG. Recente la costituzione dell’ambito turistico Terre di Siena: l’omonimo consorzio per l’olio d’oliva DOP risale invece agli anni ’90.

L’Emilia-Romagna offre un caso contemporaneo particolarmente interessante con le etichette Food Valley e Motor Valley, che promuovono prodotti turistici del territorio (le eccellenze alimentari e le eccellenze dell’alta velocità).
Ma il toponimo più emblematico in questo senso è la Costa Smeralda: un nome “a beneficio di turista” coniato a tavolino e ufficializzato davanti a un notaio dall’imprenditore Giuseppe Mentasti nel 1962. Non per i riflessi verdeazzurri delle acque ma in onore della figlia Esmeralda – intelligentemente privata della “E” per far suonare il nome “più italiano.”
Tracce umane dal passato
Non mancano poi i luoghi definiti dai popoli che li hanno vissuti in tempi antichi: la Costa degli Etruschi in Toscana e la Riviera degli Etruschi in Lazio lasciano poco spazio all’immaginazione. Ma troviamo anche associazioni meno immediate: il Tigullio ligure discende dai Tigulli, popolazione preromana protagonista di scontri con i Galli e destinata a soccombere all’avanzare dell’Impero Romano. Tenacemente, resiste ancora nel nome della bellissima area del Centro Levante.
Il lascito preistorico più importante del nostro Paese, e di prestigio internazionale, è però la Valle Camonica – che agli antichi Camuni deve sia il nome che le preziose incisioni rupestri, valse al territorio l’etichetta ulteriore di Valle dei Segni, ovviamente patrimonio dell’umanità UNESCO.

E tra i segni della Valle Camonica ce n’è uno davvero difficile da dimenticare: la Rosa Camuna, scelta nel 1975 come simbolo ufficiale dalla Regione Lombardia nella stilizzazione grafica di Bruno Munari, Bob Noorda, Roberto Sambonet e Pino Tovaglia. L’impronta dei Camuni esce così dai confini della Valle per raccontare l’intero territorio regionale. E diventare una delle grandi realizzazioni grafiche del secondo Novecento.
Conclusioni
Un nome non è una semplice etichetta: custodisce una memoria culturale e storica, racconta una comunità, a volte è testimonianza di un’evoluzione linguistica o di un cambiamento sociale e politico. Aspetti, questi ultimi, a cui si dedica con un approccio interdisciplinare la toponomastica critica, analizzando il significato dei nomi attribuiti a un luogo e il loro impatto sulla memoria collettiva.
Anche in ambito turistico, quindi, raccontare il territorio attraverso un nome non è una scelta neutra: equivale ad assumersi la responsabilità di contribuire alla narrazione di quel luogo. È un lavoro di ricerca, interpretazione e sintesi di un sentire comune, per approdare a una definizione che non sia solo evocativa ma, soprattutto, capace di rappresentare.