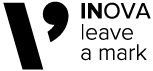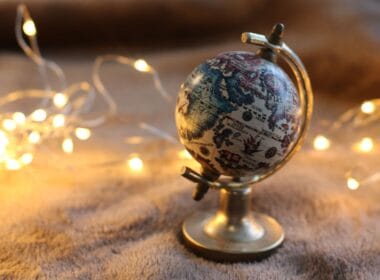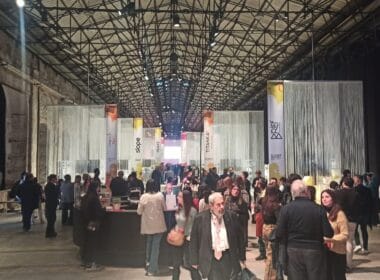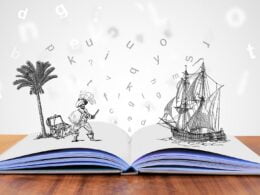Dalla Grecia di Omero alle città invisibili di Calvino: come la letteratura ha costruito l’immaginario dei luoghi e continua a generare viaggi, desideri e geografie interiori.
A Giovanna, alla sua forza.
Concludiamo questo numero bimestrale di INova dedicato alla costruzione dell’immaginario turistico — e non solo turistico — attraverso le arti e le forme di espressione che non nascono con l’intento di comunicare o promuovere luoghi e territori, ma che finiscono comunque per farlo, con una panoramica sulla letteratura.
Proveremo a chiederci se, e in che modo, la letteratura abbia influito sulla percezione collettiva dei luoghi e, dunque, sul modo in cui immaginiamo e interpretiamo il mondo che ci circonda.
Prima, però, un breve riepilogo dei contributi precedenti di questo numero.
Nel primo articolo, Paola Iacona ci ha mostrato come l’arte visiva — la pittura prima, la street art oggi — sia stata e continui a essere motore di significazione e risemantizzazione dei luoghi. Senza gli impressionisti non esisterebbe la Francia. O meglio, non esisterebbe quella Francia che, da oltre un secolo, ispira partenze e viaggiatori.
Sara Boero ci ha raccontato come il cinema, in poco più di cent’anni, abbia ribaltato ogni paradigma artistico, restituendoci la forza viva e concreta dell’immagine in movimento, senza distinzioni tra cinema d’autore e cinema mainstream. Abbiamo esplorato il cinema al di là del cinema. Oggi, come accadde settant’anni fa, sono le serie — Netflix e non solo — a imporsi come nuovi strumenti di costruzione dell’immaginario. E con pieno merito.
Se la Francia, per come la immaginiamo (e soprattutto per come vogliamo ritrovarla), l’hanno fatta gli impressionisti, allora non possiamo che riconoscere al cinema americano la capacità di costruzione simbolica di quel Paese. L’America — usata in antonomasia per gli Stati Uniti — è stata edificata nella nostra mente di europei del XX e XXI secolo, dalle immagini del cinema: da Godzilla a Sex and the City.
Giacomo Addario ci ha poi emozionato, facendoci ricordare — e inevitabilmente riascoltare — quelle canzoni, italiane e straniere, che hanno segnato, oltre al loro tempo, anche lo spazio del nostro immaginare: terre e luoghi che non abbiamo mai visto e che, forse, non vedremo mai.
Si dice, giustamente, che la musica è universale. Ma cosa sarebbe l’Italia senza il belcanto dell’opera lirica? E cosa sarebbero i Caraibi, l’Estremo Oriente o l’Africa senza la loro naturale colonna sonora, che ha contribuito — chissà quanto e perché — a farceli immaginare proprio così come li pensiamo?
C’è un pensiero che nasce attraversando i luoghi e un altro che si forma restando fermi, in salotto. I luoghi ispirano nuovi pensieri, ma i pensieri generano nuovi luoghi. Forse non è altro che il rapporto eterno tra noi e ciò che per noi è “l’esotico”, l’Altro da noi. Sapendo che, anche se non ci saremo mai, potremo sempre chiudere gli occhi e… immaginare di esserci.
Fantasticare, a occhi aperti o chiusi, prima di partire per una nuova meta; per scoprire se sarà come ce l’avevano raccontata, o come l’avevamo immaginata. Perché non smetteremo mai di costruire ricordi — anche di ciò che non abbiamo ancora vissuto.
E se pensiamo alla letteratura e alla sua relazione con i luoghi, non possiamo che riconoscerle il ruolo di massima espressione artistica dell’egemonia culturale di un popolo, di una città, di un Paese. La letteratura, come forma di espressione umana, è grande dove prosperano anche le altre arti, insieme alla società e all’economia che le generano.
Prima che un luogo venga rappresentato, viene raccontato. La parola crea mondi, li popola, li consegna all’immaginario collettivo. L’immaginazione letteraria è il più potente dispositivo di costruzione simbolica dello spazio: fa esistere paesaggi che diventano poi reali, o che finiscono per esserlo perché qualcuno, leggendo, ha desiderato raggiungerli.
L’immagine della Grecia, dai Romani a oggi, è certamente cambiata nei secoli; ma quanto hanno contribuito a costruirla, e ricostruirla, l’Iliade e l’Odissea? Il mito dell’Ellade non è ancora finito e continua a essere motore di “turismo”.

Spesso si dice che la letteratura romana non abbia saputo essere grande come quella greca. Probabilmente è così. Ma Roma Caput Mundi ha significato anche il latino — prima dell’inglese — come lingua internazionale. La letteratura, a differenza della musica, non è un linguaggio universale, ma una lingua universalistica fa grande la sua letteratura e i suoi significati, anche simbolici. Solo pochi mesi fa tutto il mondo ha assistito, in un misto di sincera fede e ateo stupore, alla pronuncia dalla loggia centrale di San Pietro: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”. Roma non ha bisogno di altri turisti, anche per “colpa” e “fortuna” di questa frase, che ormai è rito e mito. Letteratura. Iscrizione.
L’Alto Medioevo è stato francese, anche per la letteratura. I poemi cavallereschi, il ciclo bretone e quello carolingio: Re Artù, i cavalieri della Tavola Rotonda. Quel Medioevo, che ritroviamo nei castelli dei nostri viaggi europei, è stato riletto — architettonicamente — proprio grazie e attraverso quella sua letteratura al confine del fantastico, dal movimento neogotico di fine Ottocento. Un nome su tutti: Viollet-le-Duc. Ma qui stiamo invadendo un campo che non è nostro.
Quanti borghi, paesi e città italiane si intestano – spesso inopportunamente – un verso dantesco, il campione della letteratura volgare, il primo autore mondiale dopo i classici. E se si pensa a letteratura e paesaggio, come non citare il suo concittadino Petrarca e il racconto dell’ascensione al Monte Ventoso, in Francia, vicino ad Avignone, o meglio a Vaucluse: il luogo del buen retiro petrarchesco, ancora oggi meta dei “pellegrini” dei paesaggi letterari.

Oggi a Gerusalemme, con dolore, non è possibile fare turismo. Una città simbolo delle tre religioni di Abramo: l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. Le religioni muovono ancora di più della letteratura: la loro forza nel costruire il nostro immaginario è potenzialmente infinita. E tutte, o quasi, sono prima di ogni altra cosa un libro: parola divina. “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio” (Gv 1,1). Ogni musulmano deve fare un viaggio alla Mecca, così ogni induista deve bagnarsi nel Gange.
Il Seicento è stato il secolo spagnolo. Come non intravedere nei mulini a vento del paesaggio ondulato della Castiglia-La Mancia il profilo di Don Chisciotte, appeso e scaraventato. La Spagna ringrazia Cervantes. Così come l’Italia ringrazia Leopardi, non solo per il mare dolce delle colline marchigiane nel quale naufragare, ma per tutti i luoghi leopardiani del Bel Paese, diventati inevitabile meta di turismo letterario.
A scuola, Leopardi lo accompagniamo a Foscolo e Manzoni. Ecco i Colli Euganei di Jacopo Ortis; e, facendo un balzo indietro nel tempo ma poco lontano nello spazio, ci sono Romeo e Giulietta, anzi, una città. “Non esiste mondo fuor dalle mura di Verona, ma solo purgatorio, tormento, inferno”, dice Shakespeare. Ci spostiamo in Lombardia, a Lecco, dove troviamo altri due innamorati traditi dall’arroganza del potere e dalla banalità del male della piccola gente: Lucia lascia il suo luogo del cuore per poter, alla fine, amare Renzo. “Addio, monti sorgenti dall’acque ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente […]” (Manzoni, I promessi sposi).

Troppo frettoloso, forse, il catalogo che ci porta al secolo scorso: alla Sicilia di Verga, alla Trieste di Svevo, alla Dublino di Joyce, alla Macondo di García Márquez, all’Africa di Conrad, alla Lisbona di Pessoa, alle Langhe di Pavese. E ci riporta a Villa Adriana, a Tivoli, duemila anni fa, con in mano Le memorie di Adriano della Yourcenar.
Esistono città invisibili che vivono solo nella parola — come quelle di Calvino — eppure sono entrate nel nostro vocabolario mentale come se potessimo visitarle davvero. La letteratura costruisce così un atlante immaginario parallelo, in cui le coordinate non sono geografiche. I luoghi letterari diventano luoghi simbolici: rappresentano un’idea di civiltà, un’identità collettiva, un modo di stare al mondo.
La parola ha preceduto l’immagine, e la letteratura ha anticipato la comunicazione turistica. I territori diventano “leggibili” perché prima sono stati scritti: la pagina ha generato il desiderio del viaggio.
Oggi, nell’epoca dell’istantaneo, la letteratura conserva una forza lenta e profonda, capace di restituire senso e interiorità all’esperienza del luogo. Mentre le piattaforme digitali ci mostrano il mondo in tempo reale, la parola scritta ci invita a rileggerlo, a reinterpretarlo, a immaginarlo di nuovo. È un atto di resistenza culturale: la letteratura difende il valore del tempo, dell’attesa, dell’immaginazione individuale. Ci insegna che il turismo non è solo movimento, ma relazione — con il paesaggio, con la memoria, con noi stessi.
Così, la letteratura diventa la più sostenibile delle arti del viaggio. Non consuma, ma rigenera; non fotografa, ma rielabora; non fissa, ma trasforma. Ogni lettore è un viaggiatore potenziale e ogni libro un invito a partire, anche restando fermi.
Forse, in fondo, è questo il senso ultimo del viaggio e dell’immaginario che lo precede: leggere il mondo per scriverlo di nuovo.
Adesso possiamo riaprire gli occhi e scegliere il prossimo libro — e il prossimo viaggio — intorno alla nostra camera da letto o verso la nostra personale frontiera, verso il Far West:
William Least Heat-Moon, Blue Highways: A Journey into America, 1982.
Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre, 1794.